Il pieno e il vuoto: riflessioni sul “vedere” e il “mostrare”
Il regista Terrence Malick con The tree of life e To the wonder conduce lo spettatore a una sorta di sindrome di Stendhal. di Gianni Olla
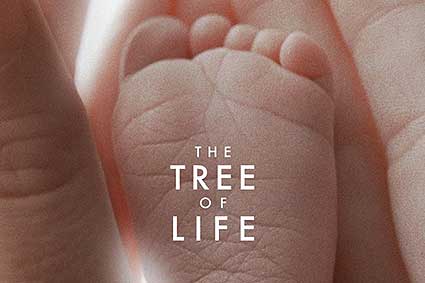 Rivisti frequentemente in tv, anche a pezzi, gli ultimi due film di Malick, The Tree of Life (2011) e To the Wonder (2013), sembrano voler obbligare lo spettatore, soprattutto se già conosce le trame, comunque poco agibili, a concentrarsi sulla gran mole di dati visivi presenti in ogni inquadratura: dalle foglie che volano via al frequente scorrere dell’acqua del fiume, all’immersione in quelle stesse acque purificatrici, ai fili d’erba, ai dettagli di un corpo infantile, ai caotici movimenti di macchina che esplorano altri corpi, ma anche volti, case, stanze, fabbriche e paesaggi.
Rivisti frequentemente in tv, anche a pezzi, gli ultimi due film di Malick, The Tree of Life (2011) e To the Wonder (2013), sembrano voler obbligare lo spettatore, soprattutto se già conosce le trame, comunque poco agibili, a concentrarsi sulla gran mole di dati visivi presenti in ogni inquadratura: dalle foglie che volano via al frequente scorrere dell’acqua del fiume, all’immersione in quelle stesse acque purificatrici, ai fili d’erba, ai dettagli di un corpo infantile, ai caotici movimenti di macchina che esplorano altri corpi, ma anche volti, case, stanze, fabbriche e paesaggi.
Ed infine, proprio in The Tree of Life, l’esile diegesi è continuamente interrotta dalle esplosioni di terribile bellezza cosmica, così distanti dalla vita quotidiana dell’uomo da potersi solo contemplare, magari in una sorta di sinfonia cine-musicale che mescola assieme Mozart e Mahler, Bach e Berlioz, nonché Respighi, Schuman, ed un imprecisato numero di altri brani, anche contemporanei, scritti o assemblati da Alexandre Desplat.
 Nel film più recente, altresì, il contrasto tra il “meraviglioso” del titolo e la tristezza esistenziale di tutti i protagonisti – ovvero dell’uomo e del suo vivere in un mondo fisico totalmente indifferente e persino capace di ribellarsi al suo apparente dominio – è confinato in una trama apparentemente più semplice, diciamo sentimentale, ma sempre ostacolata da una problematica coscientizzazione.
Nel film più recente, altresì, il contrasto tra il “meraviglioso” del titolo e la tristezza esistenziale di tutti i protagonisti – ovvero dell’uomo e del suo vivere in un mondo fisico totalmente indifferente e persino capace di ribellarsi al suo apparente dominio – è confinato in una trama apparentemente più semplice, diciamo sentimentale, ma sempre ostacolata da una problematica coscientizzazione.
Persino la bellezza, “divina”, dell’arte, rappresentata dall’abbazia di Mont Saint Michel, è una materializzazione filmica quasi interamente sensitiva, ai margini del monumento, con il gioco dei due amanti nella marea che dovrebbe simbolizzare il salire e il scendere della loro passione, e soprattutto la vitalità della protagonista femminile, vittima del suo stesso entusiasmo.
Entrambi i film possono essere definiti come “corporei” e, alla stesso, interiorizzati, quasi che il regista voglia oltrepassare l’involucro fisico che cela l’anima o la psiche dei propri protagonisti.
 Ovviamente, la “corporeità” di To the Wonder supera quella del primo titolo, in ragione della sua essenza sentimentale che, in teoria, dovrebbe opporsi al bagliore para (o pseudo) filosofico di The Tree of Life, che ha avuto l’onore di un commento del celebre studioso Emanuele Severino. Ciò ha determinato una paradossale sottovalutazione del secondo film, che pure è anch’esso una straordinaria riflessione sul dolore e la solitudine, ad ogni latitudine e in ogni scenario, anche se illuminato dalla “meraviglia” della creazione umana, e non solo divina.
Ovviamente, la “corporeità” di To the Wonder supera quella del primo titolo, in ragione della sua essenza sentimentale che, in teoria, dovrebbe opporsi al bagliore para (o pseudo) filosofico di The Tree of Life, che ha avuto l’onore di un commento del celebre studioso Emanuele Severino. Ciò ha determinato una paradossale sottovalutazione del secondo film, che pure è anch’esso una straordinaria riflessione sul dolore e la solitudine, ad ogni latitudine e in ogni scenario, anche se illuminato dalla “meraviglia” della creazione umana, e non solo divina.
Ma per tornare al discorso iniziale, i due film sono accomunati, appunto, da una forma marcatissima con la quale il regista vuole non solo segnare il proprio sguardo esterno, oggettivo, attraverso una quantità di dati visivi in cui è facile perdersi, ma anche evidenziare il medesimo sguardo da parte dei protagonisti: delle continue e quasi soffocanti soggettive virtuali – cioè senza cancellare le figure dei protagonisti – che rafforzano l’idea di una tempesta emotiva, derivante dal rapporto tra l’interiorità individuale e la realtà cosmica.
 Il paradosso di queste scelte linguistiche e formali – non certamente nuove, ma sicuramente estremizzate da Malick – è che il pubblico delle sale, diverso da quello festivaliero (The Three of Life ha vinto la Palma d’oro a Cannes), ha avuto una gamma di reazioni piuttosto variegate: dall’entusiasmo assoluto al rifiuto, passando per una sorta di coinvolgimento puramente emotivo che appare come una “Sindrome di Stendhal” assolutamente non patologica, ma piuttosto basata su un entusiasmo prevalentemente sensoriale.
Il paradosso di queste scelte linguistiche e formali – non certamente nuove, ma sicuramente estremizzate da Malick – è che il pubblico delle sale, diverso da quello festivaliero (The Three of Life ha vinto la Palma d’oro a Cannes), ha avuto una gamma di reazioni piuttosto variegate: dall’entusiasmo assoluto al rifiuto, passando per una sorta di coinvolgimento puramente emotivo che appare come una “Sindrome di Stendhal” assolutamente non patologica, ma piuttosto basata su un entusiasmo prevalentemente sensoriale.
Se dovessimo seguire le indicazioni di un bel volume di Noël Burch, Il lucernario dell’infinito, era questo il senso spettacolare/attrattivo del cinematografo delle origini non documentario, ovvero non legato alle attualità dei fratelli Lumiere, dipendente da altre forme di spettacolo (il circo, il teatro, l’illusionismo, il varietà), dotato di tecnologie avanzate – per l’epoca – ma privo di un’estetica specifica e cosciente.
 Tutto questo accadeva nei primi dieci anni del Novecento, prima che si affermassero dei canoni di uniformità linguistica (trama comprensibile, linearità narrativa, centralità dei personaggi, varietà dei piani di ripresa, movimento virtuale attraverso il montaggio delle inquadrature, campo definito come una quinta teatrale) che servivano ad una comprensione e ad una partecipazione standardizzata per gran parte del pubblico mondiale.
Tutto questo accadeva nei primi dieci anni del Novecento, prima che si affermassero dei canoni di uniformità linguistica (trama comprensibile, linearità narrativa, centralità dei personaggi, varietà dei piani di ripresa, movimento virtuale attraverso il montaggio delle inquadrature, campo definito come una quinta teatrale) che servivano ad una comprensione e ad una partecipazione standardizzata per gran parte del pubblico mondiale.
Il riapparire di un flusso visivo emozionale, ultima conseguenza delle rivoluzioni formali del dopoguerra e, nello stesso tempo, materializzazione tecnologica della “camera stylo” di Alexander Astruc, rischia però, nell’estremizzazione di Malick, di evocare paradossalmente un’altra sindrome, quella patologica descritta da Borges in un suo celebre racconto, Funes o della memoria.
Il protagonista che dà il nome allo scritto, dopo una caduta da cavallo, perde completamente la capacità di ragionare, ma acquista una memoria retrospettiva capace di citare con esattezza fatti assolutamente insignificanti. Scrive Borges: “Nel mondo sovraccarico di Funes, non c’erano che dettagli, quasi immediati.
 Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini d’una pergola. Ricordava le forme delle nubi australi dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata d’un libro che aveva visto una sola volta, o con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la vigilia della battaglia di Quebracho. Questi ricordi non erano semplici: ogni immagine visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche ecc. Poteva ricostruire tutti i sogni dei suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia”.
Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini d’una pergola. Ricordava le forme delle nubi australi dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata d’un libro che aveva visto una sola volta, o con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la vigilia della battaglia di Quebracho. Questi ricordi non erano semplici: ogni immagine visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche ecc. Poteva ricostruire tutti i sogni dei suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia”.
È chiaro che il paradosso borgesiano è anche una allegoria del funzionamento “normale” di una memoria che seleziona. E, facilmente, si può aggiungere, anche del meccanismo del vedere, di per se, selezionante anche se non sempre ordinante.
Ma, allontanandoci dall’ironia di Borges – costruttore di mondi fittizi e forse inutili, ancorché teoricamente perfetti come La Biblioteca di Babele – eccoci a Joyce a al suo monologo interiore, che non può che avere alle spalle una visione non selezionante. Ma la scrittura letteraria richiede una soglia di attenzione certamente più bassa dell’immagine filmica - o della visione “tout court” – e può essere sempre “recuperata” e “meditata” in tempi più lunghi rispetto alle durate canoniche dei film.
 In ogni caso, anche il cinema di Malick, dimostra che il rapporto tra cinema e letteratura travalica il confronto tra le opere specifiche, romanzesche e filmiche, per lavorare invece, come scrive Antonio Costa, sull’effetto “rebound” tra i due linguaggi, il che comprende appunto anche la letterarietà dei dialoghi e dei monologhi, non necessariamente tratti da specifiche opere romanesche, teatrali o saggistiche.
In ogni caso, anche il cinema di Malick, dimostra che il rapporto tra cinema e letteratura travalica il confronto tra le opere specifiche, romanzesche e filmiche, per lavorare invece, come scrive Antonio Costa, sull’effetto “rebound” tra i due linguaggi, il che comprende appunto anche la letterarietà dei dialoghi e dei monologhi, non necessariamente tratti da specifiche opere romanesche, teatrali o saggistiche.
Tornando alle ultime pellicole dell’autore statunitense, ne consegue che la prima osservazione specificamente filmica riguarda le caratteristiche dell’inquadratura, che potremmo definire “piena”, colma di dettagli apparentemente insignificanti che occupano gran parte dello spazio visivo e auditivo entro il quale lo spettatore deve districarsi come può, impossibilitato a seguire un ordine quasi mai dettato dal racconto “invisibile”, ma più spesso, immergendosi, quasi inconsciamente, nel caos e tentando di riordinarne i frammenti.
 È stato Lino Miccichè, nella sua recensione di Apocalypse now di Coppola, a utilizzare l’idea della pienezza schermica, ipotizzando un linguaggio stracarico di suggestioni spettacolari, di dettagli, di avvenimenti, di oggetti, personaggi, contrasti cromatici, tipico del cinema hollywoodiano, o per meglio dire, in quel film particolare, di una società dello spettacolo che tutto “ingloba”, dalla cronaca alla finzione, per restituirlo nella sua pienezza visiva allo spettatore, non lasciandogli alcuno spazio di riflessione.
È stato Lino Miccichè, nella sua recensione di Apocalypse now di Coppola, a utilizzare l’idea della pienezza schermica, ipotizzando un linguaggio stracarico di suggestioni spettacolari, di dettagli, di avvenimenti, di oggetti, personaggi, contrasti cromatici, tipico del cinema hollywoodiano, o per meglio dire, in quel film particolare, di una società dello spettacolo che tutto “ingloba”, dalla cronaca alla finzione, per restituirlo nella sua pienezza visiva allo spettatore, non lasciandogli alcuno spazio di riflessione.
Non è un caso che, proprio in Apocalypse now, una sequenza importante, fortemente allegorica, mostri lo stesso regista intento a girare delle scene di guerra “in diretta”. La spettacolarizzazione bellica di quella sequenza allude ai “reels” che, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, dominavano la cronaca televisiva statunitense, coinvolgendo emotivamente gli spettatori e determinando, come hanno sottolineato molti storici, una crescente ostilità verso le scelte belliche del governo statunitense.
 L’alternativa alla pienezza della “società dello spettacolo”, nel 1979, anno di uscita del film di Coppola, era il linguaggio essenziale, quasi spoglio, del cinema europeo d’autore. Gli echi delle “vagues” che avevano dominato la cultura filmico-intellettuale del ventennio precedente erano ancora fortissimi a livello critico e accademico, e potevano mettere in campo numerosi autori di cinema il cui linguaggio si basava appunto più sui “vuoti” (Anghelopulos, Antonioni, Bergman, giusto per citare i più noti) che sui “pieni”.
L’alternativa alla pienezza della “società dello spettacolo”, nel 1979, anno di uscita del film di Coppola, era il linguaggio essenziale, quasi spoglio, del cinema europeo d’autore. Gli echi delle “vagues” che avevano dominato la cultura filmico-intellettuale del ventennio precedente erano ancora fortissimi a livello critico e accademico, e potevano mettere in campo numerosi autori di cinema il cui linguaggio si basava appunto più sui “vuoti” (Anghelopulos, Antonioni, Bergman, giusto per citare i più noti) che sui “pieni”.
Ma il confronto tra i due estremi di “mise en cadre” non può essere relegato solo ad una questione geografica. Per esemplificare, ai vuoti di Antonioni, che rimandano alla pittura di un Morandi, e comunque ad una visione “scarnificata” dei sentimenti e della realtà visibile, ridotta a segni grafici, si può opporre la pienezza del grande cinema, spesso pittorico-letterario-musicale, e di derivazione otto/novecentesca, di Visconti. E alla pienezza, anche letteraria, e non solo pittorica, di Jean Renoir, i silenziosi e dolorosi vuoti del giansenista Bresson, alla ricerca disperata di una grazia che riempia di vita gli esseri umani.
 E infine, allo splendore barocco di Fellini, le cui “pieghe” (Deleuze) spettacolari nascondono comunque il dolore, si possono contrapporre le “isole” di Bergman, vuote geograficamente e spiritualmente..
E infine, allo splendore barocco di Fellini, le cui “pieghe” (Deleuze) spettacolari nascondono comunque il dolore, si possono contrapporre le “isole” di Bergman, vuote geograficamente e spiritualmente..
Ma anche nel cinema hollywoodiano ci imbattiamo in una contrapposizione quasi ideologica tra pieni e vuoti: i film western di John Ford, ambientati, in larga parte nella Monument Valley, ovvero in un deserto da cui emergono i resti di un mondo originario: le grandiose pietre, ma anche i valorosi e “sconfitti” abitanti dell’America precoloniale. Il vuoto del deserto, nella sua filmografia dedicata alla frontiera dell’ovest è poi progressivamente riempito dal “giardino” della civiltà. Ciò che rimane del deserto – appunto la Monument Valley – provoca, nell’autore d’origine irlandese, una sorta di “madeleine” proustiana, per citare un bel volume di Leutrat e Guigues, Le carte del western.
 Ma per tornare a Malick, anche il suo cinema – che, inizialmente e persino in To the Wonder, ha avuto tra i suoi modelli, i pieni e i vuoti fordiani, ovvero una vera propria nostalgia per l’America originaria delle grandi praterie – si è mosso con cautela entro i confini dell’inquadratura.
Ma per tornare a Malick, anche il suo cinema – che, inizialmente e persino in To the Wonder, ha avuto tra i suoi modelli, i pieni e i vuoti fordiani, ovvero una vera propria nostalgia per l’America originaria delle grandi praterie – si è mosso con cautela entro i confini dell’inquadratura.
Il suo primo lungometraggio, La rabbia giovane (ma il titolo originale, Badlands, è molto più significativo), girato nel 1973, è un “road-movie” che cancella la mitologia della riscoperta dell’America nascosta e ancora primordiale, alla Ford – mito cinematografico per eccellenza di quegli anni – per raccontare una storia criminale “scarnificata”. Ma il paesaggio, appunto, è ancora vuoto e i personaggi agiscono, ma non sembrano avere memoria e emozioni che possano creare un atteggiamento “riempitivo”.
Nel secondo titolo, I giorni del cielo (1979), la portata cupa e quasi feroce della trama – due ragazze e un ragazzo che lavorano, durante la mietitura, in una fattoria del Texas e approfittano della bontà del giovane “feudatario” malato – oscilla tra i vuoti paesaggistici del western e la pienezza delle scene di massa, del lavoro nei campi, della vita alla fattoria, per poi, quasi manieristicamente, inventarsi una sorta di anticipo epico dell’indifferenza della natura: le cavallette che devastano il raccolto vengono visualizzate attraverso una fotografia macro, che le riprende in dettaglio, quasi extra diegeticamente.
 Ma la svolta formale avviene – con vent’anni di attesa, causati da lutti familiari e crisi personali del regista – con il film successivo, La sottile linea rossa (1998), ispirato molto liberamente ad un romanzo di James Jones, ambientato nel Pacifico, durante la seconda guerra mondiale.
Ma la svolta formale avviene – con vent’anni di attesa, causati da lutti familiari e crisi personali del regista – con il film successivo, La sottile linea rossa (1998), ispirato molto liberamente ad un romanzo di James Jones, ambientato nel Pacifico, durante la seconda guerra mondiale.
Come il più celebre romanzo dello scrittore, Da qui all’eternità (poi film diretto da Zinnemann), anch’esso ambientato durante la guerra contro i giapponesi, la pellicola di Malick sembra sottintendere una sorta di elogio della diserzione. Motivato, per la prima volta nella sua filmografia, proprio da un panteismo (i primi quaranta minuti del film sono ambientati in un villaggio della Melanesia in cui alcuni soldati vivono pacificamente fuori dal tumulto bellico) che la guerra distrugge.
Così i “vuoti “primordiali” e i “pieni” bellici, caotici, disgregati in sequenze e inquadrature quasi slegate da ogni sintesi narrativa, sono unificati da un lento monologare interiore dei personaggi – in particolare Jim, interpretato da James Cavieziel – anch’esso in grado di saturare la scena e di far esplodere la tensione quasi oltre i confini dell’inquadratura.
 In The New World (2005) è presente una simile impostazione formale, tendente inizialmente ad un’epica ad un tempo aggressiva e pacificante, rappresentata dall’arrivo delle navi inglesi, nel 1607, in un territorio americano che corrisponde all’attuale Virginia.
In The New World (2005) è presente una simile impostazione formale, tendente inizialmente ad un’epica ad un tempo aggressiva e pacificante, rappresentata dall’arrivo delle navi inglesi, nel 1607, in un territorio americano che corrisponde all’attuale Virginia.
Il preludio wagneriano de L’Oro del Reno sembra evocare la ricerca di altri dei, di un paradiso successivamente incarnato nella principessa Pocahontas.
Ribaltando la forma del precedente film, il “pieno”, questa volta, è la comunità indiana, talmente complessa e ritualizzata, nonché misteriosa dal punto di vista delle relazioni umane, che non è “penetrabile” dai coloni bianchi.
Non c’è un mondo magico, esotico, in cui ritirarsi, come nel Pacifico sconvolto dalla guerra, ma un’ostilità che si apre solo grazie al sentimento.
Il vuoto, in questo caso, non solo circoscrive la vita stentata dei coloni, ma si manifesta, successivamente, nell’ordine artificiale della natura: i parchi inglesi che accolgono i “nativi” americani ospiti del re d’Inghilterra, sono dei segni grafici incomprensibili e certamente innaturali.
 Il passaggio al dittico successivo (Tree of Life, To the Wonder) rimanda per certi versi a La sottile linea rossa, con la costruzione di un monologo interiore che diventa il vero filo conduttore del film, frantumato e “coscientizzato” in un flusso che, come già si è scritto, ricorda Joyce.
Il passaggio al dittico successivo (Tree of Life, To the Wonder) rimanda per certi versi a La sottile linea rossa, con la costruzione di un monologo interiore che diventa il vero filo conduttore del film, frantumato e “coscientizzato” in un flusso che, come già si è scritto, ricorda Joyce.
Ma a questa interiorizzazione fa riscontro, appunto, una pienezza schermica altrettanto “coscientizzata” e quasi interamente “memorializzata”. Soprattutto in The Tree of Life, ciò che viene comunemente definito “extra diegesi”, cerca sempre di sovrastare il racconto, che peraltro, è costituito soprattutto di evocazioni e di “scene mancate”, cioè del “non detto” e “non visto” e forse “non accaduto” se non, appunto, nell’interiorità dei personaggi.
È anche evidente che la problematica esistenziale di La sottile linea rossa, soffocata dalla trama bellica, abbia finito per esplodere proprio nei due ultimi due titoli che riguardano interamente il personaggio uomo e l’indifferenza della natura – e della stessa cultura – di fronte al suo dolore senza fine e senza rimedio.
A questo punto basta sostituire il termine natura con quello di Dio, e siamo già nella filmografia centrale di un altro grande regista/filosofo, Ingmar Bergman, che abbiamo citato in apertura come un perfetto rappresentante del “vuoto” schermico.
 Per essere più precisi, non tutto il cinema di Bergman ha una forma visiva prevalentemente orientata verso il “vuoto”. A parte gli esordi – in cui comunque campeggiano i richiami contrastanti all’isolamento di Un’estate d’amore (1951) e Monica e il desiderio (1953) – il suo primo capolavoro, Il posto delle fragole (1957), è certamente un film “pieno”, drammaturgicamente e visivamente, la cui ritualità rimanda ad una teatralità classica cecoviana
Per essere più precisi, non tutto il cinema di Bergman ha una forma visiva prevalentemente orientata verso il “vuoto”. A parte gli esordi – in cui comunque campeggiano i richiami contrastanti all’isolamento di Un’estate d’amore (1951) e Monica e il desiderio (1953) – il suo primo capolavoro, Il posto delle fragole (1957), è certamente un film “pieno”, drammaturgicamente e visivamente, la cui ritualità rimanda ad una teatralità classica cecoviana
Allo stesso modo anche Sussurri e grida (1972) è un film prevalentemente “pieno”, anche dal punto coloristico, e nonostante i temi: la malattia, il dolore, la famiglia, la morte, evidentemente riassorbiti dalla memoria della protagonista malata, che, di nuovo, come un personaggio cecoviano, evoca, in una biancore abbagliante – il vuoto della memoria ma anche della morte – i momenti felici passati accanto alle sorelle.
E, ovviamente, è un film “pienissimo” Fanny e Alexander (1984), falsa biografia bergmaniana – quella vera l’ha raccontata nel libro Lanterna magica – in cui anche l’accumulo di oggetti, e non solo di personaggi, è quasi una metafora della felicità, del teatro giocoso in cui si muove il giovane Alexander, che verrà poi distrutto dalla spoglia e vuota desolazione conventuale dell’abitazione del patrigno, il vescovo Vergerus, che oltretutto richiama il padre reale del regista.
 Insomma, il vuoto è, in larga misura, sofferenza e dolore, ed è facile concentrarsi appunto, non solo su alcuni suo grandi film considerati “minori” (Dopo la prova, Un mondo di marionette, I due beati), nonché sull’ultimo suo capolavoro, Sarabanda, ma principalmente, sulla cosiddetta trilogia del “silenzio di Dio” (Come in uno specchio, Luci d’inverno, Il silenzio), realizzata tra il 1961 e il 1963, ma i cui temi riappaiono in Persona (1966), L’ora del lupo (1968), La vergogna (1968), Passione (1969).
Insomma, il vuoto è, in larga misura, sofferenza e dolore, ed è facile concentrarsi appunto, non solo su alcuni suo grandi film considerati “minori” (Dopo la prova, Un mondo di marionette, I due beati), nonché sull’ultimo suo capolavoro, Sarabanda, ma principalmente, sulla cosiddetta trilogia del “silenzio di Dio” (Come in uno specchio, Luci d’inverno, Il silenzio), realizzata tra il 1961 e il 1963, ma i cui temi riappaiono in Persona (1966), L’ora del lupo (1968), La vergogna (1968), Passione (1969).
Questi “kammerspiel” di derivazione “strindberghiana”, sono caratterizzati dall’isolamento dei personaggi, talvolta in cerca di una rinascita, altre volte convinti di poter allontanare il passato e di riavvicinarsi alla vita attraverso l’amore, quasi sempre frustrato. È anche probabile che le diverse sequenze di To the Wonder in cui il sacerdote interpretato da Javier Bardem invoca, in un continuo monologo interiore, la presenza di un Dio che non si manifesta mai, siano delle volute citazioni di Luci d’inverno, il cui protagonista, un pastore protestante, officia il rito religiosa in una chiesa semivuota, circondata da un paesaggio nevoso e da una comunità totalmente indifferente, chiusa nel proprio dolore.
In ogni caso i luoghi del cinema bergmaniani degli ultimi quarant’anni sono quasi sempre delle isole e i personaggi si tengono dentro le loro sofferenze indicibili, parlano poco, hanno difficoltà di contatti umani, sono soffocati da un’introversione del tutto opposta alla caotica reazione verso l’esterno – cioè alla ricerca di pieni nella natura e nelle bellezze del mondo – che caratterizza The Tree of Life e To theWonder.
 Ovviamente, queste scelte formali non possono essere solo il risultato di estetiche diverse, ma di vere e proprie derivazioni culturali, antropologiche, religiose, filosofiche.
Ovviamente, queste scelte formali non possono essere solo il risultato di estetiche diverse, ma di vere e proprie derivazioni culturali, antropologiche, religiose, filosofiche.
Nel caso di Bergman, il silenzio di Dio e del mondo sensibile che schiaccia gli esseri umani, è, inizialmente un portato del luteranesimo e successivamente quasi un’incarnazione del pensiero di Kierkegaard, con le sue chiusure solipsistiche, le sue prigioni mentali, compensate da una piacere momentaneo, sostituto dell’amore, e da un’impotenza totale nei confronti di ogni cambiamento; soprattutto nella totale sfiducia in un Dio che si ritiene indifferente alla disperazione umana.
È altresì paradossale che nel nuovo mondo, anch’esso permeato da una cultura anti cattolica, prevalentemente puritana, ci sia invece una reazione al silenzio di Dio.
Per questo l’invasione schermica di Malick è anche una sorta di rigetto dell’introversione: il bisogno di sfidare la natura indifferente, di proclamare comunque, anche nella sconfitta, il primato dell’uomo.
5 novembre 2014

