Sorrentino, come Fellini, non sogna più.
Gli ultimi film del regista riminese, scomparso nel 1993, ci hanno raccontato un mondo segnato dalla disillusione e della morte della poesia. Il regista napoletano attualizza quella profezia. Memorie d’oltrecinema. La cineteca di Gianni Olla
Prova d’orchestra (1979), La città delle donne (1980), Ginger e Fred (1985), La voce della luna (1990) di Federico Fellini, Loro 1 e 2(2018) di Paolo Sorrentino, Videocracy (2013) di Erik Gandini
Nonostante la definizione, un po’ occasionale, di una categoria filmica apposita, il “cinema del reale”, la scrittura del reale, cioè qualcosa che ha dei punti di convergenza con il mondo vissuto dalla maggior parte degli “umani”, è diventata, da almeno trent’anni, un problema complicato per chi si prova a raccontare il presente con gli strumenti del cinema.
 Naturalmente, va chiarito che l’affidarsi ad un racconto già incasellato entro delle categorie tradizionali – i famosi, anche se mai rigidi, generi cinematografici – risolve il problema attraverso un realismo di superficie, o anche profondo, ma pur sempre creativo e non puramente documentario. Una commedia, un melodramma, una tragedia sono sempre in agguato per riportare, anche in maniera convincente, lo spettatore ad uno specchio del reale riconoscibile e partecipato. Mi viene in mente, per caso, un film recente, Manchester by sea di Kenneth Lonergan, vincitore del premio oscar 2016 per la miglior sceneggiatura: un concentrato di generi, appunto, che riesce a rappresentare benissimo la vita della classe media, o medio bassa americana (senza che questo dato sia programmatico o ideologico), attraverso un racconto biografico che utilizza, appunto, i generi classici: melodramma e tragedia, ricomposti e destrutturati secondo logiche narrative al passo con i tempi post-post-post “nouvelle vague”.
Naturalmente, va chiarito che l’affidarsi ad un racconto già incasellato entro delle categorie tradizionali – i famosi, anche se mai rigidi, generi cinematografici – risolve il problema attraverso un realismo di superficie, o anche profondo, ma pur sempre creativo e non puramente documentario. Una commedia, un melodramma, una tragedia sono sempre in agguato per riportare, anche in maniera convincente, lo spettatore ad uno specchio del reale riconoscibile e partecipato. Mi viene in mente, per caso, un film recente, Manchester by sea di Kenneth Lonergan, vincitore del premio oscar 2016 per la miglior sceneggiatura: un concentrato di generi, appunto, che riesce a rappresentare benissimo la vita della classe media, o medio bassa americana (senza che questo dato sia programmatico o ideologico), attraverso un racconto biografico che utilizza, appunto, i generi classici: melodramma e tragedia, ricomposti e destrutturati secondo logiche narrative al passo con i tempi post-post-post “nouvelle vague”.
Ma sempre di uno specchio del reale si tratta, senza troppe invenzioni esistenziali che potrebbero creare un surplus di irrealtà. Un esempio opposto e apparentemente più complicato, sul piano interpretativo, è un film recentissimo, Wajib - Invito al matrimonio di Annemarie Jacir, film di produzione palestinese, girato e ambientato a Nazareth, nel nord d’Israele, tra la popolazione araba e per lo più cristiana. La trama è semplicissima: padre e figlio (il primo abbandonato dalla moglie, che si è risposata negli Stati Uniti; il secondo residente, da tempo, in Italia), entrambi arabi, devono consegnare a mano, secondo la tradizione, le partecipazioni per il matrimonio della figlia e sorella. Attraverso questo circoscritto road-movie, che ricorda l’apparente denotazione del cinema di Kiarostami e del suo allievo Panhai (Taxi Tehran), emerge una descrizione credibile della vita di un villaggio arabo che fa parte integrante del territorio israeliano e, nello stesso tempo, pone un interrogativo al singolo spettatore: sei in grado di decifrare le idee e le sensazioni, nonché il senso di accettazione o di frustrazione, che i personaggi si portano dietro nei loro percorsi rituali e cerimoniali?
Qui, insomma, il realismo funziona al contrario: deve essere sviscerato direttamente dal pubblico che, magari, considerato il contesto, può non sapere che quel paese arabo, quegli abitanti palestinesi, quell’unico cittadino ebreo che mai si vede ma che pure è il preside della scuola nella quale insegna uno dei due personaggi, sono cittadini a pieno titolo dello stato d’Israele. In ogni caso, i parametri di verosimiglianza ci autorizzano a scrivere che ciò che non appare, in questo film, appartiene alla nostra perdonabile ignoranza storico-geografica e che il film, in realtà, appartiene pienamente ad un realismo classico, direi zavattiniano, ovvero capace di mostrare i personaggi anche nella loro quotidianità, apparentemente insignificante. Ma c’è anche, e cresce in maniera esponenziale, una forma filmica che, programmaticamente, “survolta” la realtà, o meglio la fa esplodere attraverso diversi modelli estetici, non necessariamente formalizzati rigidamente. Il ricorso al surrealismo – più o meno legato agli esiti visivi di un Dalì che non a Buñuel – o all’iperrealismo, tipico del cinema di genere americano, a partire dagli anni Sessanta, sono già dei modi di invitare il pubblico a leggere il mondo attraverso una sua possibile dissoluzione formale e, ovviamente, contenutistica.
Da qui partono tutte le tentazioni fantastiche e tutte le trasfigurazioni possibili del reale, dai film inseriti nel sottogenere “young adults”, che occhieggiano al classico di Huxley, Il mondo nuovo, spesso dimenticato, per raccontare, appunto, delle realtà distopiche nei quali tutto è predeterminato, in vista di una possibile felicità e ordine che ha cancellato completamente il libero arbitrio, o quel poco che ne resta, almeno mentalmente, nella vita degli uomini. E, poi, in termini ancora formali, il grottesco, il comico, e ogni altra forma, spesso già ingabbiata in categorie più o meno rigide, che, di nuovo, leggono il mondo nelle sue paradossali distorsioni, che magari ci fanno ridere ma sono anche amarissime. E, per finire, abbiamo il lascito filmico, quasi unico e non racchiudibile in alcun genere – anche se dipende da tanti altri modelli estetici, descritti nelle righe precedenti – di Federico Fellini, nei cui confini convergono l’arricciarsi infinita della rappresentazione barocca, la comicità surreale di tanti personaggi, il sogno di vite diverse e impossibili, la trasfigurazione del ricordo e della stessa memoria storica.
 Il punto chiave di questo difficile discorso ha inizio con una confessione irrituale. Ogni volta che rivedo, a caso, uno di questi quattro film (Prova d’orchestra, La città delle donne, Ginger e Fred, La voce della luna) che appartengono alla sua ultima fase creativa – girati appunto tra il 1979 e il 1990, cioè tre anni prima della sua scomparsa – sono “disturbato” da una sorta di senso di colpa. Lascio fuori da questo discorso gli altri due film dello stesso periodo, E la nave va (1983) e Intervista (1988), in parte perché avrei bisogno di rivedere il primo film, cancellando il ricordo della visione veneziana del 1983, quando, inevitabilmente, quella pellicola, a suo modo storico-fantastica come due suoi precedenti capolavori come Satyricon (1969) e Il Casanova (1976), andò a cozzare contro Fanny & Alexander di Bergman, vero evento di quell’edizione, che oscurò ogni altra opera. Dunque, sospendo il giudizio e intanto valuto un capolavoro autentico l’autobiografico Intervista, che, oltretutto, è un grande lezione di composizione filmica felliniana, in cui la realtà – documentaria, appunto – viene sovvertita continuamente dalla finzione e, a sua volta, la sovverte con la pretesa di raccontare il vero Fellini. Tornando ai quattro titoli iniziali, brutalmente, li considero intrisi di banalità.
Il punto chiave di questo difficile discorso ha inizio con una confessione irrituale. Ogni volta che rivedo, a caso, uno di questi quattro film (Prova d’orchestra, La città delle donne, Ginger e Fred, La voce della luna) che appartengono alla sua ultima fase creativa – girati appunto tra il 1979 e il 1990, cioè tre anni prima della sua scomparsa – sono “disturbato” da una sorta di senso di colpa. Lascio fuori da questo discorso gli altri due film dello stesso periodo, E la nave va (1983) e Intervista (1988), in parte perché avrei bisogno di rivedere il primo film, cancellando il ricordo della visione veneziana del 1983, quando, inevitabilmente, quella pellicola, a suo modo storico-fantastica come due suoi precedenti capolavori come Satyricon (1969) e Il Casanova (1976), andò a cozzare contro Fanny & Alexander di Bergman, vero evento di quell’edizione, che oscurò ogni altra opera. Dunque, sospendo il giudizio e intanto valuto un capolavoro autentico l’autobiografico Intervista, che, oltretutto, è un grande lezione di composizione filmica felliniana, in cui la realtà – documentaria, appunto – viene sovvertita continuamente dalla finzione e, a sua volta, la sovverte con la pretesa di raccontare il vero Fellini. Tornando ai quattro titoli iniziali, brutalmente, li considero intrisi di banalità.
 Il termine è terribile – e mi scuso per averlo usato – peggiore di brutto e di “non riuscito”, che almeno rubricano, nel primo caso, un gusto personale – e in questo caso, c’è poco da obiettare – e, nel secondo, l’ovvia constatazione che nessuno è perfetto ed anche i maestri possono produrre opere minori, incerte, imperfette. La banalità, invece, riguarda una messa in discussione della poetica di un autore, o almeno di una parte della sua creatività : come se quelle opere fossero state ideate e poi dirette non dal regista riminese ma da un suo imitatore, indubbiamente scaltro, ma non in grado di replicare la creatività del vero Fellini. Il caso limite è certamente l’ultimo titolo, La voce della luna, che ho visto non appena messo in programmazione, in sala, e che ho recensito a caldo giudicandolo, per farla breve, “un film senza sorprese”, oltre che senza speranza, come affermavano i medici che avevano in cura il dubbioso alter-ego del regista (Mastroianni/Guido) in uno dei suoi capolavori, Otto e mezzo (1963). Tutto questo ben 28 anni fa. Poi ho rivisto il film sullo schermo televisivo, forse immediatamente dopo la morte del regista, e successivamente non ho avuto più modo di vederlo. Solo qualche mese fa, volontariamente, dopo aver trovato un Dvd a prezzo stracciato, ho deciso di rifare i conti con quella pellicola.
Il termine è terribile – e mi scuso per averlo usato – peggiore di brutto e di “non riuscito”, che almeno rubricano, nel primo caso, un gusto personale – e in questo caso, c’è poco da obiettare – e, nel secondo, l’ovvia constatazione che nessuno è perfetto ed anche i maestri possono produrre opere minori, incerte, imperfette. La banalità, invece, riguarda una messa in discussione della poetica di un autore, o almeno di una parte della sua creatività : come se quelle opere fossero state ideate e poi dirette non dal regista riminese ma da un suo imitatore, indubbiamente scaltro, ma non in grado di replicare la creatività del vero Fellini. Il caso limite è certamente l’ultimo titolo, La voce della luna, che ho visto non appena messo in programmazione, in sala, e che ho recensito a caldo giudicandolo, per farla breve, “un film senza sorprese”, oltre che senza speranza, come affermavano i medici che avevano in cura il dubbioso alter-ego del regista (Mastroianni/Guido) in uno dei suoi capolavori, Otto e mezzo (1963). Tutto questo ben 28 anni fa. Poi ho rivisto il film sullo schermo televisivo, forse immediatamente dopo la morte del regista, e successivamente non ho avuto più modo di vederlo. Solo qualche mese fa, volontariamente, dopo aver trovato un Dvd a prezzo stracciato, ho deciso di rifare i conti con quella pellicola.

È facile ribadire che il film sia senza speranza, ma questo è, appunto, un dato che riguarda interamente il vero Fellini, fin da La strada (1954), e non l’ipotizzato suo sosia dell’ultimo titolo. Invece, per quanto riguarda l’eventuale sorpresa – non pervenuta – si deve fare un discorso più articolato. La voce della luna è ispirata a Il poema dei lunatici (1987), un romanzo dello scrittore reggiano Ermanno Gavazzoni, il quale narra del vagabondaggio surreale di un certo Savini (nel film Salvini) e del suo compagno occasionale che si fa chiamare Prefetto Gonnella. L’uno è alla ricerca di pozzi che parlano e di altre condutture acquee popolate di essere umani, l’altro vede complotti dappertutto e pensa addirittura che la zona da loro esplorata sia, in realtà, percorsa da una guerra perenne tra invisibili fazioni armate. Nel film i personaggi sono abbastanza fedeli alle descrizioni letterarie ma, da un lato, non sempre percorrono le loro strade insieme, dall’altro Fellini li caratterizza in maniera molto marcata, affidando i ruoli ad attori famosi, specializzati, si può ben dire, in ambito comico-farsesco: Roberto Benigni per Salvini, Paolo Villaggio per Gonnella. Aggiungo che il regista sovrappone alle descrizioni di Gavazzoni una propria traccia poetica autonoma, visibile soprattutto nel personaggio principale, costruito attraverso due richiami letterari.
 Il primo, che si riflette anche fisiognomicamente in tanti ritratti e illustrazioni che appaiono nel film, è Giacomo Leopardi, il poeta di una contemplazione memoriale che, di nuovo, appartiene interamente al vero Fellini. Il secondo è Pinocchio, il burattino/bambino che il regista avrebbe voluto portare sullo schermo, appunto con Roberto Benigni che poi, nel 2002, lo girerà per conto suo, senza peraltro fare faville. La mescolanza dei due personaggi si concentra in una sorta di esplorazione di un paese dei balocchi, ricostruito in un set scintillante di plastica e metallo che sovrasta e vampirizza progressivamente le poche tracce di una campagna autenticamente padano-romagnola, ovvero pienamente felliniana, fin da La strada e prima di La dolce vita (1960), suo approdo alla città. Ma Pinocchio/Leopardi si intristisce per tanta artificialità da brutta sagra paesana. Cerca la bellezza, qui e ora, ma solo il ricordo – migliore della vita, dice alla fine – sembra salvarlo. Tutto il resto è artificio, ed anche in mezzo alla pianura piena di memorie e di sogni, spicca una gigantesca discoteca, in cui la nuova gioventù balla, urla e strepita.
Il primo, che si riflette anche fisiognomicamente in tanti ritratti e illustrazioni che appaiono nel film, è Giacomo Leopardi, il poeta di una contemplazione memoriale che, di nuovo, appartiene interamente al vero Fellini. Il secondo è Pinocchio, il burattino/bambino che il regista avrebbe voluto portare sullo schermo, appunto con Roberto Benigni che poi, nel 2002, lo girerà per conto suo, senza peraltro fare faville. La mescolanza dei due personaggi si concentra in una sorta di esplorazione di un paese dei balocchi, ricostruito in un set scintillante di plastica e metallo che sovrasta e vampirizza progressivamente le poche tracce di una campagna autenticamente padano-romagnola, ovvero pienamente felliniana, fin da La strada e prima di La dolce vita (1960), suo approdo alla città. Ma Pinocchio/Leopardi si intristisce per tanta artificialità da brutta sagra paesana. Cerca la bellezza, qui e ora, ma solo il ricordo – migliore della vita, dice alla fine – sembra salvarlo. Tutto il resto è artificio, ed anche in mezzo alla pianura piena di memorie e di sogni, spicca una gigantesca discoteca, in cui la nuova gioventù balla, urla e strepita.
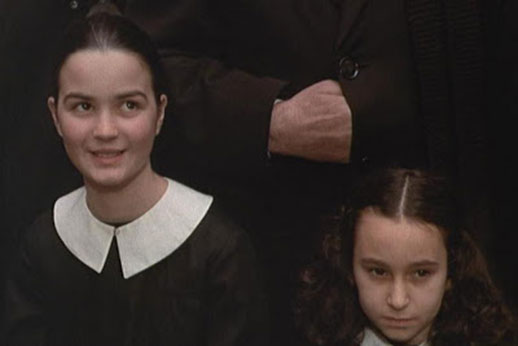 La lunga sequenza della discoteca mette di nuovo in comunicazione il suo ultimo film con il passato: nel lungo e bellissimo finale di Roma (1970), dopo il finto documentario sulla città eterna; dopo il ricordo della sua Roma, pre e post bellica; dopo la discesa agli inferi nel Grande Raccordo Anulare; dopo l’ascesa ad un cielo religioso e papalino, surreale e irriverente, appare solamente la città, di notte. I grandi monumenti sono illuminati a giorno e le larghe strade invase da centinaia di motociclisti che le percorrono verso chissà quale meta: le nuove legioni barbariche evocano il punto di non ritorno di quella “scristianizzazione” che molti osservatori (da Vittorini e Pasolini) avevano letto in trasparenza in La dolce vita. In La voce della luna, insomma, tutto si tiene, persino l’Aldina di Amarcord – sogno proibito del giovane protagonista, Titta – ormai adulta e sempre inaccessibile allo sguardo di Salvini. Ma è tutto troppo facile, senza sorprese, senza la possibilità di scavare a fondo oltre la denotazione del racconto e delle immagini. E il primo indizio di questa banalizzazione è paradossalmente il cast, che Fellini non ha mai sbagliato. Qui, invece, oltre alla presenza di due attori molto caratterizzati – e Villaggio sembra appunto un Fantozzi incattivito, benché sempre succube di un mondo che lo schiaccia – che finiscono per essere soprattutto se stessi, c’è uno stuolo di caratteristi che, egualmente, si portano appresso un’identificazione autoreferenziale.
La lunga sequenza della discoteca mette di nuovo in comunicazione il suo ultimo film con il passato: nel lungo e bellissimo finale di Roma (1970), dopo il finto documentario sulla città eterna; dopo il ricordo della sua Roma, pre e post bellica; dopo la discesa agli inferi nel Grande Raccordo Anulare; dopo l’ascesa ad un cielo religioso e papalino, surreale e irriverente, appare solamente la città, di notte. I grandi monumenti sono illuminati a giorno e le larghe strade invase da centinaia di motociclisti che le percorrono verso chissà quale meta: le nuove legioni barbariche evocano il punto di non ritorno di quella “scristianizzazione” che molti osservatori (da Vittorini e Pasolini) avevano letto in trasparenza in La dolce vita. In La voce della luna, insomma, tutto si tiene, persino l’Aldina di Amarcord – sogno proibito del giovane protagonista, Titta – ormai adulta e sempre inaccessibile allo sguardo di Salvini. Ma è tutto troppo facile, senza sorprese, senza la possibilità di scavare a fondo oltre la denotazione del racconto e delle immagini. E il primo indizio di questa banalizzazione è paradossalmente il cast, che Fellini non ha mai sbagliato. Qui, invece, oltre alla presenza di due attori molto caratterizzati – e Villaggio sembra appunto un Fantozzi incattivito, benché sempre succube di un mondo che lo schiaccia – che finiscono per essere soprattutto se stessi, c’è uno stuolo di caratteristi che, egualmente, si portano appresso un’identificazione autoreferenziale.

Proviamo a spiegare questa straordinaria anomalia nel modo di costruire una drammaturgica che dovrebbe essere tipicamente felliniana. Una delle chiavi del suo mondo poetico è sempre stato il rapporto strettissimo tra la costruzione di bozzetti pittorici dei propri personaggi, non ancora cinematografici, e, in parallelo, nel cercare una sorta di specchio fotografico che ha finito per creare un grande archivio di volti anonimi ma disponibili anche ad una sola posa, se questa era necessaria a determinate caratterizzazioni. Ma in La voce della luna, molti personaggi, secondari o meno, sono già riconoscibili come protagonisti, nella vita reale, dello stesso percorso spettacolare replicato dal film. Proviamo a identificarli: Angelo Orlando, Susy Blady, Vito Micheluzzi, Roberto Roversi, Eraldo Turra. Dopo vent’anni, sono quasi spariti sia dagli schermi della tv, sia dai palcoscenici, ed è stato difficile, anche per me, non tanto riconoscerli quanto dar loro un nome e una identità. Con un po’ di pazienza ho ricordato che quei volti e quei nomi furono, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, degli attori/registi (di sé medesimi, quasi sempre) che passavano dal teatro-cabaret alla tv, allora in fase di trasformazione selvaggia, con una comicità che travolgeva i vecchi generi.
 Erano personaggi di un’opera buffa post moderna che, facilmente, potevano essere notati da un Fellini, artista che l’opera buffa la trovava, precedentemente, nelle strade e nel suo straordinario archivio fotografico di gente comune. Ma appunto, questo travaso di “normalità” surreale dalla vita allo schermo o al palcoscenico, in La voce della luna è il primo sintomo di un collasso della creatività non tanto estetica quanto profetica. Dietro quelle maschere che incarnano il “già visto”, appare infatti anche una realtà ormai non solo percepita dagli spettatori fino alla stanchezza ma già messa in scena, quotidianamente, proprio negli schermi televisivi. L’unica autentica profezia che guarda al futuro è il cartellone con la squadra di calcio del Milan e dei suoi eroi, guidati da un personaggio, Silvio Berlusconi, già famoso per aver appunto inventato le televisioni commerciali, imbottite di spot pubblicitari che interrompevano i film. Come è noto, Fellini si espose personalmente, a partire dalla fine degli anni Ottanta, in una impossibile battaglia – “Non s’interrompe un’emozione”, sponsorizzata dai Democratici di sinistra guidati da Walter Veltroni – contro l’eccesso di tali pause pubblicitarie nei film.
Erano personaggi di un’opera buffa post moderna che, facilmente, potevano essere notati da un Fellini, artista che l’opera buffa la trovava, precedentemente, nelle strade e nel suo straordinario archivio fotografico di gente comune. Ma appunto, questo travaso di “normalità” surreale dalla vita allo schermo o al palcoscenico, in La voce della luna è il primo sintomo di un collasso della creatività non tanto estetica quanto profetica. Dietro quelle maschere che incarnano il “già visto”, appare infatti anche una realtà ormai non solo percepita dagli spettatori fino alla stanchezza ma già messa in scena, quotidianamente, proprio negli schermi televisivi. L’unica autentica profezia che guarda al futuro è il cartellone con la squadra di calcio del Milan e dei suoi eroi, guidati da un personaggio, Silvio Berlusconi, già famoso per aver appunto inventato le televisioni commerciali, imbottite di spot pubblicitari che interrompevano i film. Come è noto, Fellini si espose personalmente, a partire dalla fine degli anni Ottanta, in una impossibile battaglia – “Non s’interrompe un’emozione”, sponsorizzata dai Democratici di sinistra guidati da Walter Veltroni – contro l’eccesso di tali pause pubblicitarie nei film.
 Tale crociata, assolutamente motivata ma anche destinata alla sconfitta da una sorta di apocalittica penetrazione televisiva nella vita dei cittadini, portò ad un referendum, che si svolse nel 1995, quando il regista era già scomparso, e che portò alla vittoria, di non larga misura, dei cittadini favorevoli alle interruzioni pubblicitarie. Vale la pena di stupirsi non solo per l’anomalo quesito referendario che oggi sarebbe improponibile o verrebbe preso per uno scherzo, ma anche perché votarono ben 27 milioni di italiani, circa il sessanta per cento dell’elettorato. In un film recente, piuttosto bello, Viva la libertà (2013) di Roberto Andò, un regista orientale, di stanza a Parigi, mentre discute di cultura e di imbarbarimento delle società moderne con il segretario del partito della sinistra italiana (alias il PD ancora non travolto dalla crisi apocalittica odierna ma già oscillante nel vuoto), mostra appunto un Fellini “furioso” che inveisce contro la volgare e offensiva pubblicità televisiva. Dopo di lui, sembra suggerisce quell’intromissione, siamo precipitati nel baratro dell’incultura. Tornando a La voce della luna, le immagini di Berlusconi e del suo Milan, visto la sua successiva e non troppo lontana carriera politico-commerciale, interamente votata alla completa unificazione di vita, spettacolo, affari e politica, fanno sorridere.
Tale crociata, assolutamente motivata ma anche destinata alla sconfitta da una sorta di apocalittica penetrazione televisiva nella vita dei cittadini, portò ad un referendum, che si svolse nel 1995, quando il regista era già scomparso, e che portò alla vittoria, di non larga misura, dei cittadini favorevoli alle interruzioni pubblicitarie. Vale la pena di stupirsi non solo per l’anomalo quesito referendario che oggi sarebbe improponibile o verrebbe preso per uno scherzo, ma anche perché votarono ben 27 milioni di italiani, circa il sessanta per cento dell’elettorato. In un film recente, piuttosto bello, Viva la libertà (2013) di Roberto Andò, un regista orientale, di stanza a Parigi, mentre discute di cultura e di imbarbarimento delle società moderne con il segretario del partito della sinistra italiana (alias il PD ancora non travolto dalla crisi apocalittica odierna ma già oscillante nel vuoto), mostra appunto un Fellini “furioso” che inveisce contro la volgare e offensiva pubblicità televisiva. Dopo di lui, sembra suggerisce quell’intromissione, siamo precipitati nel baratro dell’incultura. Tornando a La voce della luna, le immagini di Berlusconi e del suo Milan, visto la sua successiva e non troppo lontana carriera politico-commerciale, interamente votata alla completa unificazione di vita, spettacolo, affari e politica, fanno sorridere.
Ma nel 1990 erano invece, profetiche, o meglio inutilmente profetiche: si confondevano nel caos di un mondo spettacolare che aveva assorbito il peggio della cultura di massa veicolata dalle televisioni commerciali e, a ruota, dalla Rai. E appunto il vagare di Pinocchio/Leopardi in un mondo senza poesia, nel quale manca il silenzio, ovvero la possibilità di recuperare la memoria delle piccole cose, non fa che rubricare o meglio replicare il mondo esistente o meglio quello che è ormai certificato, nella sua esistenza chiassosa e spettacolare, dai tanti canali televisivi. Così, anche la cattura finale della Luna – una bellissima trovata di sceneggiatura – si trasforma in un puro evento mediatico: la fine della poesia diventa un dibattito televisivo sciocco e popolato di personaggi, anch’essi repliche del reale, che ricalcano la vera e quotidiana televisione che si occupa del nulla, in attesa delle pubblicità.
 Poiché, non per volontà di Fellini, La voce della luna è il suo ultimo film, non si può non prendere atto che il suo sguardo “senza speranza” non sorprende più lo spettatore. Non c’è più nulla da evocare poeticamente, ma solo da replicare in una esplosione spettacolare che coincide con una realtà già formattata dalle televisioni. Ma proprio perché è la sua ultima opera, forse il percorso di normalizzazione del regista, quasi rabbioso, ha avuto inizio qualche tempo prima. Indico anche una data e un titolo, Prova d’orchestra (1979). Ricordo che provai disagio anche allora, ma ero troppo giovane per potermi fidare di quel giudizio. Però l’ho rivisto spesso e, pur continuando a non amarlo, ho cercato sempre di inserirlo nei percorsi filmografici – non vastissimi – dedicati al collasso, anche sanguinoso (è stato ideato l’anno dell’assassinio di Moro), delle utopie del decennio, alle quali Fellini non aveva mai creduto. Comunque, nell’allegoria dell’orchestra che non vuole più suonare in armonia e sotto una direzione esperta, forse non c’è più alcuna speranza, ma certo la trovata della grande palla di ferro che, nel pre-finale, tutto distrugge, è una sequenza quasi kubrickiana: la sorpresa di verificare che quel mondo di “piccole cose” – gli orchestrali, non ancora rabbiosi, che parlano dei loro strumenti – è ormai defunto e che quel direttore d’orchestra tedesco, non propriamente simpatico, ha le sue buone ragioni per imporre la dittatura del dovere.
Poiché, non per volontà di Fellini, La voce della luna è il suo ultimo film, non si può non prendere atto che il suo sguardo “senza speranza” non sorprende più lo spettatore. Non c’è più nulla da evocare poeticamente, ma solo da replicare in una esplosione spettacolare che coincide con una realtà già formattata dalle televisioni. Ma proprio perché è la sua ultima opera, forse il percorso di normalizzazione del regista, quasi rabbioso, ha avuto inizio qualche tempo prima. Indico anche una data e un titolo, Prova d’orchestra (1979). Ricordo che provai disagio anche allora, ma ero troppo giovane per potermi fidare di quel giudizio. Però l’ho rivisto spesso e, pur continuando a non amarlo, ho cercato sempre di inserirlo nei percorsi filmografici – non vastissimi – dedicati al collasso, anche sanguinoso (è stato ideato l’anno dell’assassinio di Moro), delle utopie del decennio, alle quali Fellini non aveva mai creduto. Comunque, nell’allegoria dell’orchestra che non vuole più suonare in armonia e sotto una direzione esperta, forse non c’è più alcuna speranza, ma certo la trovata della grande palla di ferro che, nel pre-finale, tutto distrugge, è una sequenza quasi kubrickiana: la sorpresa di verificare che quel mondo di “piccole cose” – gli orchestrali, non ancora rabbiosi, che parlano dei loro strumenti – è ormai defunto e che quel direttore d’orchestra tedesco, non propriamente simpatico, ha le sue buone ragioni per imporre la dittatura del dovere.
 In ogni caso, anche questo titolo è un film minore: la rabbia del Fellini cittadino si sovrappone alla grazia del Fellini artista. La tentazione di essere di nuovo un inventore di fantasie barocche appare invece in La città delle donne (1980), la cui trama oscilla tra il sogno (in treno, con a fianco la moglie) di una imprevista avventura sentimentale di Mastroianni/Snaporaz (il nomignolo fumettistico che il regista aveva coniato, fin da La dolce vita, per il suo interprete) e l’ultima “ridotta” di un Casanova (Katzone) che abita in un castello nelle cui pareti sono conservate tutte le sue memorie dongiovannesche, con tanto di sonoro e di visivo relativo alle sue prestazioni con donne bellissime. La città delle donne, in apparenza, sembra in sintonia con le tante variazioni sul tema dell’Io dell’artista (da Otto e mezzo a Giulietta degli spiriti, passando per il cortometraggio Le tentazioni del dottor Antonio (1963) e per l’affresco, anche autobiografico, di Roma. Solo che i tempi sono cambiati. Tra il sogno e la realtà fattuale, ci sono le femministe che contestano il nostro Snaporaz: era successo davvero, nella realtà, con il regista, eletto a emblema di maschilismo esasperato fino alla misoginia, assieme ai colleghi Marco Ferreri e Bernardo Bertolucci.
In ogni caso, anche questo titolo è un film minore: la rabbia del Fellini cittadino si sovrappone alla grazia del Fellini artista. La tentazione di essere di nuovo un inventore di fantasie barocche appare invece in La città delle donne (1980), la cui trama oscilla tra il sogno (in treno, con a fianco la moglie) di una imprevista avventura sentimentale di Mastroianni/Snaporaz (il nomignolo fumettistico che il regista aveva coniato, fin da La dolce vita, per il suo interprete) e l’ultima “ridotta” di un Casanova (Katzone) che abita in un castello nelle cui pareti sono conservate tutte le sue memorie dongiovannesche, con tanto di sonoro e di visivo relativo alle sue prestazioni con donne bellissime. La città delle donne, in apparenza, sembra in sintonia con le tante variazioni sul tema dell’Io dell’artista (da Otto e mezzo a Giulietta degli spiriti, passando per il cortometraggio Le tentazioni del dottor Antonio (1963) e per l’affresco, anche autobiografico, di Roma. Solo che i tempi sono cambiati. Tra il sogno e la realtà fattuale, ci sono le femministe che contestano il nostro Snaporaz: era successo davvero, nella realtà, con il regista, eletto a emblema di maschilismo esasperato fino alla misoginia, assieme ai colleghi Marco Ferreri e Bernardo Bertolucci.
 Ma, infine, il processo finale al protagonista sembra riportare Fellini al dovere di una denuncia della violenza, visto che evoca, non troppo nascostamente, il processo Moro. Si può essere violenti anche partendo da buone ragioni. Ma il vero precedente di La voce della Luna è certamente Ginger e Fred (1985), nella cui tessitura narrativa c’è un’ultima nostalgia indirettamente biografica. Difatti i protagonisti del film sono due vecchie glorie del varietà post bellico che, ormai dimenticati dal pubblico, vengono appunto invitati a partecipare ad una delle serate dedicate alle vecchie glorie del passato. I Ginger e Fred del titolo sono ovviamente legati al mito del musical americano: lei, Giulietta Masina, è ormai una nonna pacificata anche nel ricordo di quelle glorie effimere – il tratto biografico, in questo caso, è la sua progressiva assenza dagli schermi, databili al 1969 – mentre il suo ex partner è un Mastroianni male in arnese che ha vissuto di espedienti sognando di ritornare alla grandezza degli esordi. In questa ennesima ricostruzione di un mondo perduto, però, il contesto è più importante dei personaggi.
Ma, infine, il processo finale al protagonista sembra riportare Fellini al dovere di una denuncia della violenza, visto che evoca, non troppo nascostamente, il processo Moro. Si può essere violenti anche partendo da buone ragioni. Ma il vero precedente di La voce della Luna è certamente Ginger e Fred (1985), nella cui tessitura narrativa c’è un’ultima nostalgia indirettamente biografica. Difatti i protagonisti del film sono due vecchie glorie del varietà post bellico che, ormai dimenticati dal pubblico, vengono appunto invitati a partecipare ad una delle serate dedicate alle vecchie glorie del passato. I Ginger e Fred del titolo sono ovviamente legati al mito del musical americano: lei, Giulietta Masina, è ormai una nonna pacificata anche nel ricordo di quelle glorie effimere – il tratto biografico, in questo caso, è la sua progressiva assenza dagli schermi, databili al 1969 – mentre il suo ex partner è un Mastroianni male in arnese che ha vissuto di espedienti sognando di ritornare alla grandezza degli esordi. In questa ennesima ricostruzione di un mondo perduto, però, il contesto è più importante dei personaggi.
 Difatti, nel costruire l’apparizione delle due vecchie glorie, spunta per la prima volta e in maniera piuttosto critica, quasi apocalittica, una sorta di totalizzazione televisiva che ha assorbito ogni diversa e opposta visione del mondo, annacquando oltretutto la creatività in mezzo ad una pubblicità invasiva, volgare e votata al consumo vorace e indifferenziato. Si è qualcuno solo se appari in televisione, ovvero se fai parte di uno spettacolo continuo che si sovrappone al mondo reale. E non sono solo i personaggi come Ginger e Fred ad essere “trascinati” in questa carnevalata, ma anche la cultura alta, visto che il gioco delle presenze simboliche comprende anche i sosia di persone del passato, tra le quali Marcel Proust e Franz Kafka, due scrittori ai quali Fellini è stato sempre molto legato. Entrambe le maschere sono inserite in un contesto quasi carnevalesco che sottintende e forse certifica il rovesciamento definitivo della cultura “alta” in attrazione volgare e spersonalizzante. Ginger e Fred, insomma, sono testimoni di un processo di volgarizzazione del mondo che anticipa il peregrinare del protagonista di La voce della luna alla ricerca della magia della natura e che, di nuovo indica il nemico della poesia in Silvio Berlusconi e nelle sue televisioni stracariche di intervalli volgarissimi. Umberto Eco scrisse che il caos “orrorifico” di Ginger e Fred sembrava voler rifare Hieronimus Bosch. Solo che questo mondo che sta a metà strada tra Il giardino delle delizie e La nave dei folli, non era più un sogno/incubo di un artista che trasfigurava il mondo reale, ma il vero ricalco del mondo contemporaneo.
Difatti, nel costruire l’apparizione delle due vecchie glorie, spunta per la prima volta e in maniera piuttosto critica, quasi apocalittica, una sorta di totalizzazione televisiva che ha assorbito ogni diversa e opposta visione del mondo, annacquando oltretutto la creatività in mezzo ad una pubblicità invasiva, volgare e votata al consumo vorace e indifferenziato. Si è qualcuno solo se appari in televisione, ovvero se fai parte di uno spettacolo continuo che si sovrappone al mondo reale. E non sono solo i personaggi come Ginger e Fred ad essere “trascinati” in questa carnevalata, ma anche la cultura alta, visto che il gioco delle presenze simboliche comprende anche i sosia di persone del passato, tra le quali Marcel Proust e Franz Kafka, due scrittori ai quali Fellini è stato sempre molto legato. Entrambe le maschere sono inserite in un contesto quasi carnevalesco che sottintende e forse certifica il rovesciamento definitivo della cultura “alta” in attrazione volgare e spersonalizzante. Ginger e Fred, insomma, sono testimoni di un processo di volgarizzazione del mondo che anticipa il peregrinare del protagonista di La voce della luna alla ricerca della magia della natura e che, di nuovo indica il nemico della poesia in Silvio Berlusconi e nelle sue televisioni stracariche di intervalli volgarissimi. Umberto Eco scrisse che il caos “orrorifico” di Ginger e Fred sembrava voler rifare Hieronimus Bosch. Solo che questo mondo che sta a metà strada tra Il giardino delle delizie e La nave dei folli, non era più un sogno/incubo di un artista che trasfigurava il mondo reale, ma il vero ricalco del mondo contemporaneo.
Poiché, fortunatamente, Fellini non è stato archiviato, soprattutto nella memoria di tanti cineasti, anche giovani, ecco che il suo dilemma (come rapportarsi al mondo, usando la lente deformata della trasfigurazione?), ritorna nel dittico di Sorrentino, Loro 1 e Loro 2, attualmente nelle sale, attesissimi, visto che il protagonista o l’architrave del racconto è di nuovo Silvio Berlusconi, ormai personaggio cinematografico del nuovo secolo che, in futuro, sarà anche una sorta di icona simbolica di questo squarcio temporale non troppo lungo. Il dilemma estetico-rappresentativo dei due Loro di Sorrentino si distacca da altri suoi titoli recenti. In La Grande bellezza si tratta di rappresentare Roma, dopo Fellini, tra bellezza incancellabile, anche se nascosta, e trivialità da caduta dell’Impero Romano? In La giovinezza, come affrontare un bilancio esistenziale in “limine vitae”, lottando per stare a galla o semplicemente rimpiangendo il tempo perduto? Ma in entrambi i film, i protagonisti erano anche “funzioni” di un panorama generale di decadenza e di crisi: nessuno poteva riconoscersi nello scrittore/giornalista (o forse troppi potevano farlo e dunque il risultato era identico) di La grande bellezza o nel regista e nel musicista di La giovinezza.
 Invece, in Il divo e poi nella serie The Young Pope, vi sono, da una parte un uomo politico riconoscibile ma paradossalmente inconoscibile, raccontato attraverso la sua corte (ovvero I Loro del tempo), dall’altra un personaggio contradditorio, diviso tra Santità e Mondanità, entrambi strumenti del potere, sempre sofferente anche se alleggerito da personaggi e situazioni al limite della comicità. I due film sul Cavaliere, invece, hanno un limite invalicabile: Berlusconi esiste già come personaggio di un grande spettacolo continuo. La sua vita è uno spettacolo, mediocre ma di successo. In Loro 1, l’approccio a questo mondo puramente rappresentativo è indiretto, almeno fino all’apparizione di un Toni Servillo, per la prima volta attore quasi brechtiano che non si limita ad imitare Berlusconi – sarebbe facile – ma a costruirlo secondo un progetto che, come recita il titolo, si occupa della sua corte, “Loro”, lasciando la maschera del potere sullo sfondo. In questa prima parte, Berlusconi è ancora un venditore fortunato e abilissimo. Questa maschera emerge e si fortifica, prima di smarrirsi definitivamente, in Loro 2, passando inevitabilmente ad una fase da “caduta dell’impero romano”. L’uomo è definitivamente solo, in mezzo alle feste orgiastiche organizzate in suo onore. La moglie Veronica (bravissima, proprio perché “aliena” a quel mondo: è Elena Sofia Ricci) glielo ricorda nel pre finale. Ma prim’ancora, una giovanissima fanciulla che rifiuta gli approcci del cavaliere, gli dice senza alcuna remora che è vecchio e ha persino l’alito del nonno.
Invece, in Il divo e poi nella serie The Young Pope, vi sono, da una parte un uomo politico riconoscibile ma paradossalmente inconoscibile, raccontato attraverso la sua corte (ovvero I Loro del tempo), dall’altra un personaggio contradditorio, diviso tra Santità e Mondanità, entrambi strumenti del potere, sempre sofferente anche se alleggerito da personaggi e situazioni al limite della comicità. I due film sul Cavaliere, invece, hanno un limite invalicabile: Berlusconi esiste già come personaggio di un grande spettacolo continuo. La sua vita è uno spettacolo, mediocre ma di successo. In Loro 1, l’approccio a questo mondo puramente rappresentativo è indiretto, almeno fino all’apparizione di un Toni Servillo, per la prima volta attore quasi brechtiano che non si limita ad imitare Berlusconi – sarebbe facile – ma a costruirlo secondo un progetto che, come recita il titolo, si occupa della sua corte, “Loro”, lasciando la maschera del potere sullo sfondo. In questa prima parte, Berlusconi è ancora un venditore fortunato e abilissimo. Questa maschera emerge e si fortifica, prima di smarrirsi definitivamente, in Loro 2, passando inevitabilmente ad una fase da “caduta dell’impero romano”. L’uomo è definitivamente solo, in mezzo alle feste orgiastiche organizzate in suo onore. La moglie Veronica (bravissima, proprio perché “aliena” a quel mondo: è Elena Sofia Ricci) glielo ricorda nel pre finale. Ma prim’ancora, una giovanissima fanciulla che rifiuta gli approcci del cavaliere, gli dice senza alcuna remora che è vecchio e ha persino l’alito del nonno.
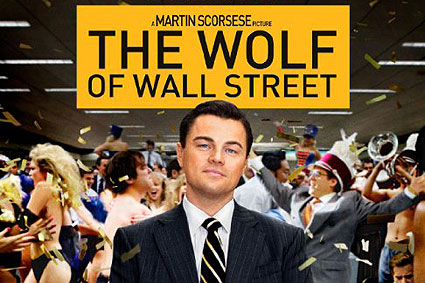
Poi il lungo epilogo, dopo il terremoto dell’Aquila – che in effetti funziona benissimo da allegoria di una caduta generale del suo carisma, ma purtroppo non del modello di dominio comunicativo da lui inaugurato – è quasi il ricalco disincantato e tardivamente patetico del grande finale di La dolce vita: la tristezza e il “tempo perduto” dopo la festa orgiastica nella villa. Qui, in aggiunta ci sono le macerie e la grande sequenza del salvataggio del Cristo trionfante dalla chiesa distrutta. Ricordiamo che la Dolce vita si apriva con il trasporto in elicottero di un Cristo trionfante: un immagine interrogativa (Cristo abbandona o corre in soccorso della città santa?) che si specchia in una caduta altrettanto interrogativa: in quel Cristo si specchia il tristissimo e invecchiato presidente, o più semplicemente, la apparizione “cristica” tra le macerie cancella la potenza ridicola del presidente del consiglio, costretto ad occuparsi di vite disperate ma inadeguato a farlo? La definizione più sintetica ed efficace del modello rappresentativo di Sorrentino appartiene ad un giornalista: il film assomiglia a The Wolf of Wall street di Martin Scorsese, con le sue feste orgiastiche continue e con l’avvitarsi del protagonista, Leonardo di Caprio, affarista senza scrupoli e ben oltre ogni limite legale, in un mondo di truffe, crimini, e denaro facile. Anche questo è un modo per riallacciarsi alla definizione di Eco su Ginger e Fred: puro Bosch. Ma è di nuovo un Bosch senza sorprese che finisce persino per occultare i veri meccanismi del potere, o del dominio, per dirla di nuovo con Brecht.
Insomma, non è un grande complimento, per Sorrentino, paragonare il suo film ad una delle poche opere decisamente brutte del regista americano. Però il modello rappresentativo è purtroppo vincente. Quotidianamente, a partire dalla metà degli anni Ottanta, abbiamo visto e vediamo tuttora in televisione e progressivamente in ogni ambito sociale – come annunciava un film che nessuno ricorda, Quinto Potere di Lumet (1977) – quelle stesse cerimonie, feste, danze, esibizioni di ragazze festanti, musica sparata, alcool, sesso, droga. Insomma, la rappresentazione grottesca coincide con il grottesco apocalittico dei nostri tempi, in politica come in tv, nella vita quotidiana così come nelle rappresentazioni di quelle stesse esistenze che si avvitano senza fine. Ecco che, a questo punto, si può archiviare il “survoltaggio” barocco della realtà riprodotta sullo schermo per affidarsi al vecchio glorioso documentario. Un film dimenticato e poco visto è infatti Videocracy di Erik Gandini, opera prodotta in Svezia nel 2012 da un giovane regista italiano. Nel contesto di una ricostruzione storica della grande rivoluzione – o della grande mutazione antropologica – scatenata dall’avvento delle tv private, la pellicola finisce per occuparsi, naturalmente, di Berlusconi, o meglio dei Loro sorrentiniani: la sua corte, o parte di essa.
Anche qui si parte dalla Costa Smeralda, e dallo stesso Berlusconi ancora in grado di comandare anche sui suoi luogotenenti politici locali, per approdare a due personaggi oggi poco visibili, dopo le “Loro” disavventure giudiziarie: Lele Mora e Fabrizio Corona. Sul secondo si sa molto, perché l’uomo ama esibirsi – lo faceva anche quando era in carcere – ma il suo personaggio è una sorta di tassello intermedio tra la parte dominante della “videocrazia” (ovvero gli apparati) e quella bassa, il pubblico quotidiano. Corona usa o ha usato il mondo dei Vip – che disprezza, come dice lui stesso – per fare i soldi; come un Robin Hood che ruba ai ricchi (attraverso le sue fotografie scomode) per dare a se stesso. Lele Mora, ripreso nella sua villa bianchissima, intonata al vestito e all’arredamento, circondato dalla corte dei suoi protetti pronti a passare nel mondo televisivo che conta, si mostra come l’ennesimo personaggio da decadenza dell’Impero romano: il maestro di cerimonie di un super Satyricon mediatico. Chi scrive deve accettare ciò che racconta il film, e cioè che Mora è stato il grande burattinaio dell’intrattenimento berlusconiano, ma certo una figura simile non avrebbe saputo tratteggiarla neanche Federico Fellini che, non a caso, come si è scritto nelle righe precedenti, stentava a mettere in scena delle invenzioni filmiche che potessero competere con la realtà.
A prescindere dalla buona volontà di Sorrentino e dalla grandezza di Toni Servillo, la società dello spettacolo, profetizzata come il “male” assoluto da Adorno (nei lontani anni Quaranta), ironizzata da Andy Warhol e demonizzata definitivamente da Guy Debord, è arrivata ad un punto di non ritorno. Loro e miliardi di altri Loro saranno i futuri profeti di un mondo finzionale che si sostituisce a quello reale, come in certi famosi film di fantascienza degli anni Cinquanta: gli alieni sono tra noi o forse gli alieni siamo noi che scriviamo o leggiamo queste righe.
24 maggio 2018

